
Regia di Ridley Scott – USA, Gran Bretagna, 2023 – 158′
con Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim
COME IL VERO NAPOLEONE, DUE VOLTE NELLA POLVERE E DUE VOLTE SULL’ALTARE, LA STORIA MESSA IN SCENA DA RIDLEY SCOTT SI DIVIDE IN DUE STRADE, TRA STRAORDINARIE SCENE DI GUERRA E UNA STORIA D’AMORE DA ROMANZO D’APPENDICE, CHE NON S’INCONTRANO MAI.
Eccolo, il Napoleon di Joaquin Phoenix. Lo troviamo subito tra la folla che attende la decapitazione di Marie Antoinette, ne seguiremo poi l’incredibile ascesa nella Francia post-rivoluzionaria, dalla battaglia di Tolone alla campagna d’Egitto, passando per la presa del potere con il colpo di stato nel 1799, la proclamazione a Imperatore dei francesi nel 1804, la battaglia di Austerlitz del 1805, arrivando poi alla disastrosa campagna di Russia, all’esilio dell’Elba, al ritorno in patria e al tentativo fallito di Waterloo, fino all’ultimo respiro sull’Isola di Sant’Elena, nel 1821, dopo sei anni di esilio.
Si salta dunque da un periodo all’altro, eludendo molto certo (d’altronde la lunghezza pur notevole del film, quasi 160’, non potrebbe mai contenere tutto) e procedendo seguendo le linee guida del “classico” film storico, incentrato però sull’ambiguità di un personaggio talmente lucido e risoluto nell’arte della guerra, tremendamente goffo e fragile altrove.
Fatta salva la solita, indiscutibile grandeur con cui il regista 85enne restituisce l’epica nelle scene di battaglia, Napoleon è un biopic plumbeo che stupisce per la scelta di non voler mai eccedere, evitando così tanto il rischio di situazioni grottesche o sopra le righe (i momenti ridicoli dell’Imperatore sono sì accennati, mai caricati troppo), ma anche il pathos che un film come Il gladiatore – sicuramente più imperfetto e più fantasioso di questo – riusciva a regalare.
La volontà è piuttosto quella di “ingabbiare” il personaggio di Napoleone in un limbo perenne dove l’egotismo e la megalomania, unitamente al genio strategico in battaglia, combattono con il sentimento d’amore che lo lega alla donna della sua vita, Giuseppina (Vanessa Kirby), moglie fedifraga, poi imperatrice, poi lasciata perché incapace di donargli l’atteso erede maschio, figura che però accompagnerà la storia di quest’uomo anche all’indomani della di lei morte.
“Francia. Esercito. Giuseppina…”, le ultime tre parole che avrebbe proferito in punto di morte Napoleone, uomo che al comando della fanteria e della cavalleria francese, nel corso di una ventina d’anni, ha ucciso più di 3 milioni di persone. Ma che ha dovuto rinunciare all’amore per lasciare se stesso alla patria.
Valerio Sammarco – Cinematografo.it
Napoleon, nuovo film sul Primo Imperatore di Francia con protagonista Joaquin Phoenix: intellettualmente ambiguo, storiograficamente preciso, dal tono schizofrenico ma esteticamente sontuoso e memorabile.
Il Napoleone di Phoenix è ironico, egocentrico, osservatore, imprenditore, ma anche outsider e si approfitta delle debolezze altrui, pensando di saperne sempre di più. Campagne militari, intrighi politici, gelosia, litigi e sesso animano la sceneggiatura.
Recensioni
6/10 Ondacinema
3,8/5 Sentieri selvaggi
4/5 Coming Soon
5 MAGGIO 1821: COSI’ MORIVA NAPOLEONE
 Napoleone chiude gli occhi per sempre sull’isola-prigione di Sant’Elena, uno scoglio sperduto nell’oceano Atlantico, a 1.900 km dalla costa africana. Ad assicurarsi lo scoop è il giornale inglese The Statesman, nell’edizione del 4 luglio 1821: due mesi dopo l’evento. La contessa de Boigne, animatrice di salotti fra Londra e Parigi, ricorderà nelle sue Memorie: «Uomini del popolo, piccoli borghesi si incontravano per strada stringendosi la mano piangendo, ma la massa dell’opinione pubblica, schierata con la monarchia, felice della pace e della prosperità ritrovata, rimase inerte».
Napoleone chiude gli occhi per sempre sull’isola-prigione di Sant’Elena, uno scoglio sperduto nell’oceano Atlantico, a 1.900 km dalla costa africana. Ad assicurarsi lo scoop è il giornale inglese The Statesman, nell’edizione del 4 luglio 1821: due mesi dopo l’evento. La contessa de Boigne, animatrice di salotti fra Londra e Parigi, ricorderà nelle sue Memorie: «Uomini del popolo, piccoli borghesi si incontravano per strada stringendosi la mano piangendo, ma la massa dell’opinione pubblica, schierata con la monarchia, felice della pace e della prosperità ritrovata, rimase inerte».

I tempi erano cambiati: l’Europa del 1821, nata dal Congresso di Vienna, non era più quella del 1815, e Napoleone non faceva più notizia. L’interesse nei confronti dell’ex imperatore si risvegliò solo due anni più tardi, sull’onda dello straordinario successo del Memoriale di Sant’Elena, dettato in gran parte da Napoleone, con l’aggiunta, da parte di Emmanuel de Las Cases (funzionario e amico dell’imperatore), di particolari della vita in esilio.
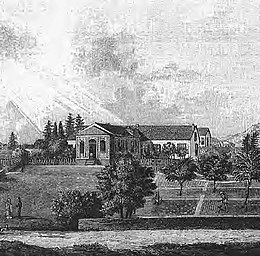 Per quasi sei anni, dal dicembre 1815, l’uomo che aveva segnato i destini d’Europa visse in un’abitazione (Longwood House) su quell’isola in mezzo al nulla dal clima malsano, caldo e umido, flagellata da venti fortissimi e senza nessuna comodità. La casa era infestata da insetti, zanzare e topi. Il circondario era sorvegliato costantemente dai gendarmi agli ordini dell’ostile governatore britannico Hudson Lowe. In quel contesto, la salute di Napoleone non poteva che peggiorare rapidamente. Il suo medico personale, l’irlandese O’Meara, gli diagnosticò un’epatite cronica. Nel 1818 il dottore fu costretto a lasciare Longwood House, perché Lowe non approvava la sua crescente familiarità con il prigioniero.
Per quasi sei anni, dal dicembre 1815, l’uomo che aveva segnato i destini d’Europa visse in un’abitazione (Longwood House) su quell’isola in mezzo al nulla dal clima malsano, caldo e umido, flagellata da venti fortissimi e senza nessuna comodità. La casa era infestata da insetti, zanzare e topi. Il circondario era sorvegliato costantemente dai gendarmi agli ordini dell’ostile governatore britannico Hudson Lowe. In quel contesto, la salute di Napoleone non poteva che peggiorare rapidamente. Il suo medico personale, l’irlandese O’Meara, gli diagnosticò un’epatite cronica. Nel 1818 il dottore fu costretto a lasciare Longwood House, perché Lowe non approvava la sua crescente familiarità con il prigioniero.
Per rimpiazzare il dottor O’Meara, il 22 settembre 1819 arrivò a Sant’Elena il chirurgo còrso Francesco Antommarchi, accompagnato dagli abati Buonavita e Vignali. Il fedele servitore Louis Marchand introdusse il medico nella stanza del malato: l’imperatore giaceva a letto in una camera piccola e oscurissima.
 Le pillole mercuriali usate frequentemente dai medici che lo curarono non fecero che peggiorare la situazione. A 51 anni Napoleone ne dimostrava venti di più: era molto sovrappeso e, nelle rare uscite in giardino, doveva appoggiarsi al braccio di Marchand. Nell’ aprile del 1821 il male (un’ulcera cancerosa: fu questa infine la causa di morte) si manifestò in tutta la sua violenza: crampi allo stomaco, vomito, vertigini, sudori abbondanti. Per mettere a suo agio il malato, fu montato il suo letto da campo nel salone, più grande e meglio areato della sua piccola stanza. E fu lì che, nel pomeriggio del 3 maggio, l’abate Vignali gli somministrò l’estrema unzione. La notte fra il 4 e il 5 maggio fu agitatissima: Napoleone delirava, parlava a stento, pronunciava parole incomprensibili. Mormorò “la France, l’armée, tête d’armée, Joséphine». Poi più nulla. La piccola corte dal mattino presto si era radunata per assisterlo fino alla fine.
Le pillole mercuriali usate frequentemente dai medici che lo curarono non fecero che peggiorare la situazione. A 51 anni Napoleone ne dimostrava venti di più: era molto sovrappeso e, nelle rare uscite in giardino, doveva appoggiarsi al braccio di Marchand. Nell’ aprile del 1821 il male (un’ulcera cancerosa: fu questa infine la causa di morte) si manifestò in tutta la sua violenza: crampi allo stomaco, vomito, vertigini, sudori abbondanti. Per mettere a suo agio il malato, fu montato il suo letto da campo nel salone, più grande e meglio areato della sua piccola stanza. E fu lì che, nel pomeriggio del 3 maggio, l’abate Vignali gli somministrò l’estrema unzione. La notte fra il 4 e il 5 maggio fu agitatissima: Napoleone delirava, parlava a stento, pronunciava parole incomprensibili. Mormorò “la France, l’armée, tête d’armée, Joséphine». Poi più nulla. La piccola corte dal mattino presto si era radunata per assisterlo fino alla fine.
Il polso era ormai debolissimo e dopo il tramonto, alle cinque e undici minuti, l’imperatore dei francesi esalò l’ultimo respiro.

MGF


 Nella storia del cinema i “film su strada” hanno fotografato anima e cultura di moltissimi Paesi e periodi storici. Quello dei road movies è uno dei generi cinematografici più iconici e peculiari di tutti, costellato da pellicole nelle quali i protagonisti sono sempre alla ricerca o in fuga da qualcuno o qualcosa. Tutto questo a bordo di veicoli iconici, entrati nel cuore di cinefili (e non solo) di tutto il mondo.
Nella storia del cinema i “film su strada” hanno fotografato anima e cultura di moltissimi Paesi e periodi storici. Quello dei road movies è uno dei generi cinematografici più iconici e peculiari di tutti, costellato da pellicole nelle quali i protagonisti sono sempre alla ricerca o in fuga da qualcuno o qualcosa. Tutto questo a bordo di veicoli iconici, entrati nel cuore di cinefili (e non solo) di tutto il mondo. I protagonisti del road movie sono in movimento per tutto il film; pertanto, sono elementi iconografici importanti i mezzi di trasporto (principalmente automobili), le riprese “a carrellata” e gli spazi aperti. I road movie del secondo dopoguerra sono stati fortemente influenzati dal romanzo Sulla strada di Jack Kerouac (1957), in quanto in esso viene delineato il futuro dei road movie, fornendo la sua principale narrativa di esplorazione, ricerca e viaggio.
I protagonisti del road movie sono in movimento per tutto il film; pertanto, sono elementi iconografici importanti i mezzi di trasporto (principalmente automobili), le riprese “a carrellata” e gli spazi aperti. I road movie del secondo dopoguerra sono stati fortemente influenzati dal romanzo Sulla strada di Jack Kerouac (1957), in quanto in esso viene delineato il futuro dei road movie, fornendo la sua principale narrativa di esplorazione, ricerca e viaggio.





 I film gotici sono quelli di un genere specifico che tenta di ricreare i temi e gli ambienti presenti nella letteratura gotica classica. I temi spesso ruotano attorno a stati emotivi ossessivi, trame familiari malvagie, il male e il soprannaturale, sebbene ce ne siano molti altri e diverse varianti. Una caratteristica distintiva di molti film gotici è l’ambientazione in cui i personaggi esistono, spesso fornendo sia l’atmosfera che il progresso della trama. Dall’inizio dell’industria cinematografica ci sono stati tentativi di creare versioni cinematografiche della letteratura gotica classica del XVIII e XIX secolo e di catturare l’essenza del genere in nuovi racconti ambientati in tempi moderni.
I film gotici sono quelli di un genere specifico che tenta di ricreare i temi e gli ambienti presenti nella letteratura gotica classica. I temi spesso ruotano attorno a stati emotivi ossessivi, trame familiari malvagie, il male e il soprannaturale, sebbene ce ne siano molti altri e diverse varianti. Una caratteristica distintiva di molti film gotici è l’ambientazione in cui i personaggi esistono, spesso fornendo sia l’atmosfera che il progresso della trama. Dall’inizio dell’industria cinematografica ci sono stati tentativi di creare versioni cinematografiche della letteratura gotica classica del XVIII e XIX secolo e di catturare l’essenza del genere in nuovi racconti ambientati in tempi moderni.


















 L’illustrazione della Divina Commedia, la sua opera più importante, consta di 243 cartoni: 73 per l’inferno, 120 per il Purgatorio e 50 per il Paradiso. Fu esposta per la prima volta a Parma nel 1870, non ancora compiuta ma già a buon punto per poter essere giudicata un capolavoro.
L’illustrazione della Divina Commedia, la sua opera più importante, consta di 243 cartoni: 73 per l’inferno, 120 per il Purgatorio e 50 per il Paradiso. Fu esposta per la prima volta a Parma nel 1870, non ancora compiuta ma già a buon punto per poter essere giudicata un capolavoro.